#22 Ci vuole un villaggio I Versione: vacanze di Natale
Un numero light della newsletter con qualche consiglio di lettura e di ascolto e una parola per l'anno che verrà
Ciao!
Eccoci con questo ultimo numero dell’anno, che cade in un giorno particolare, mentre corriamo da una parte all’altra sapendo che tanto non ce la faremo mai a spuntare tutto l’elenco delle cose da fare. E proprio per non aggiungerne alla lista una in più (leggere questa newsletter), ho pensato a un numero insolitamente sintetico, con qualche consiglio su cose da leggere, vedere e ascoltare nei prossimi giorni, che spero saranno fatti per te anche di un po’ di riposo.
E, allora, partiamo!
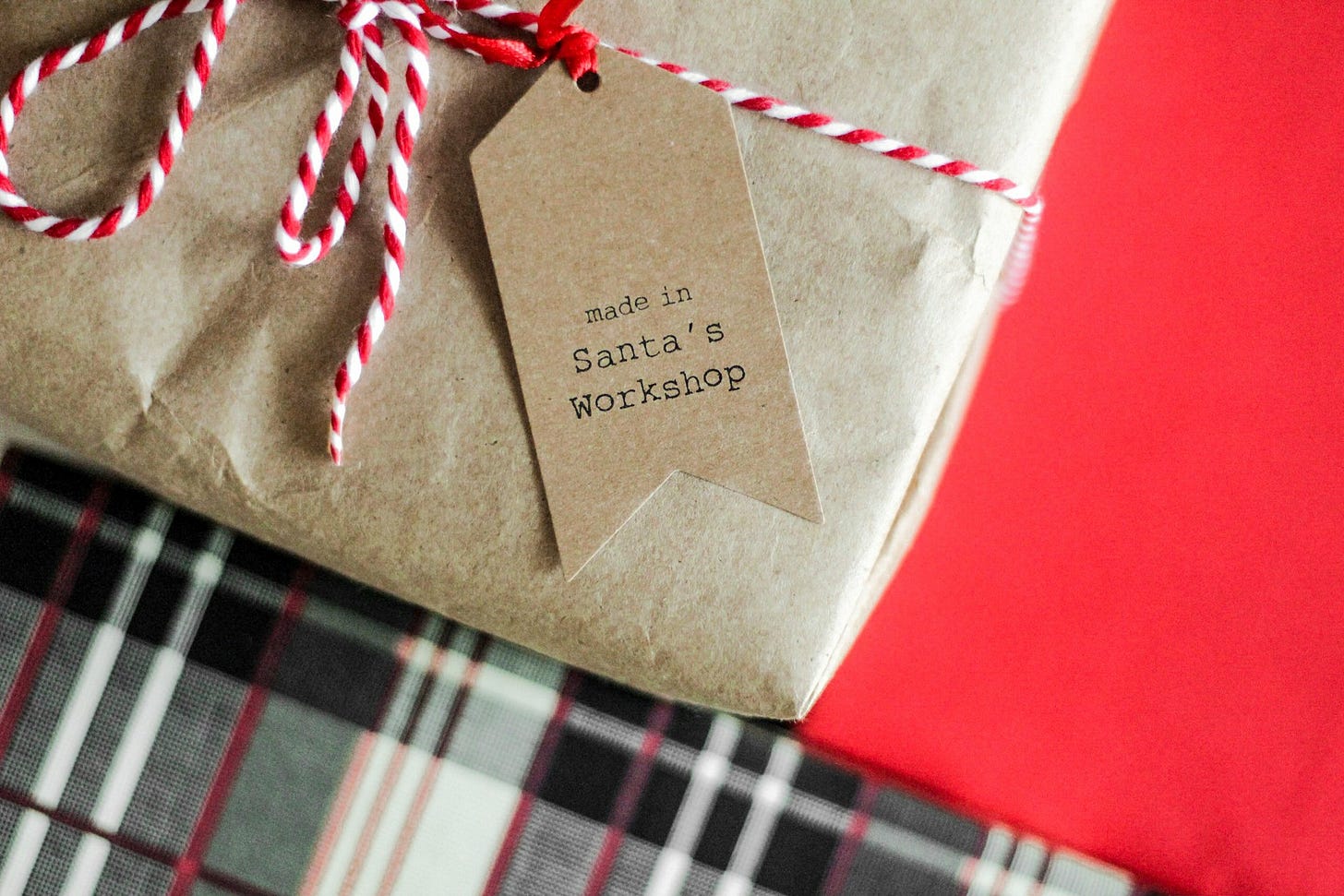
Un documento
Iniziamo con un aggiornamento. Se leggi da un po’ questa newsletter, sai che abbiamo parlato spesso di educazione digitale (ad esempio qui e qui) e dei “patti digitali”, ovvero delle alleanze tra famiglie, scuole e istituzioni nate in molti territori per accompagnare bambini e ragazzi all’uso consapevole di device, social e internet. Mesi fa scrivevo in modo particolare dell’esperienza del “Patto digitale” di Milano, che è stato accompagnato da un corposa ricerca condotta dall’Università Bicocca sul rapporto con il digitale sia dei minori che dei genitori che vivono in città. Ecco, in autunno, è stata pubblicata la parte finale di questo progetto, che contiene le “Raccomandazioni di Milano per il benessere e la sicurezza digitale di bambini/e pre-adolescenti”: sono otto punti, ognuno dei quali contiene consigli e suggerimenti su vari temi, dalla gestione dei compiti a casa su internet alla dotazione dello smartphone personale con connessione (“fortemente sconsigliata sia nel periodo della scuola primaria che in quello della secondaria di I grado”). Ti consiglio di leggerli (trovi il documento completo qui, non è lungo). Intanto, ti evidenzio due punti che mi hanno colpito. Il primo: “Una buona educazione digitale dei bambini discende dalla consapevolezza degli adulti”. Il secondo: “È importante bilanciare il tempo-schermo complessivo e lo spazio dedicato ad attività motorie e alle relazioni in presenza, che devono sempre essere privilegiate. Occorre sostenere le famiglie nel trovare adeguate alternative all’utilizzo degli schermi (attività ricreative, sportive, culturali ecc.), in modo che il loro uso avvenga nell'ambito di un equilibrio tra attività in presenza fisica e attività mediate dalle tecnologie digitali. Da questo punto di vista, è importante valorizzare e sfruttare al meglio l’offerta esistente di attività per i minori presente in città”.
Un libro (+ altri)
Venendo ai libri, il primo che ti consiglio è “Morgana. Il corpo della madre”, il volume che chiude la trilogia delle Morgane raccontate da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri esplorando, questa volta, il tema della maternità nelle sue sfaccettature altre: quelle svincolate dalla biologia e dalle narrazioni dominanti, quelle non volute, quelle smarrite, quelle volute eppure dilanianti, quelle oscure. Ci sono, tra le altre, le storie di Maria di Nazareth, Elena Ferrante e Louisa May Alcott, di Sylvia Plath, delle madri di Plaza de Mayo, di David Bowie e anche di Michela Murgia. Persone che “non avrebbero potuto, voluto e forse nemmeno dovuto essere madri, eppure lo sono state, talvolta fuori e talvolta contro il canone esprimendo della maternità anche il lato più feroce e oscuro”, spiegano Murgia e Tagliaferri.
Io lo sto ascoltando dal podcast che ha originato la serie delle Morgane e, come per le due precedenti, è un viaggio di scoperta intenso di vite eccezionali, che non sono le nostre ma le cui corde più profonde vibrano in modi che non fatichiamo a riconoscere.
A proposito di racconto della maternità, ci sono anche i romanzi proposti da Francesca Ceci nell’ultimo numero della sua newsletter
: alcuni titoli non li conoscevo e li ho subito messi in lista. È una selezione che spazia, anche geograficamente: la trovo molto interessante perché, portandoci in realtà diverse dalla nostra, rende autoevidente l’idea che la maternità sia, per forza di cose, un’esperienza ogni volta diversa.Un’inchiesta
Queste letture mi hanno ricordato una cosa che scrivevo qui esattamente un anno fa, in un numero della newsletter dedicato proprio ai libri. Ovvero, che abbiamo bisogno di rivedere la narrazione della genitorialità esplorandola più in profondità e che le storie e le parole sono strumenti potenti per farlo.
Su questo tema, ti segnalo il servizio di apertura del numero di novembre del mensile “Vita”, intitolato “Perché non vogliamo figli”, che analizza il tema dell’inverno demografico provando ad andare oltre le cause che già conosciamo, e che pure sono determinanti (la precarietà del lavoro, la congiuntura economica, le mancanze del welfare, gli squilibri di genere nella cura) partendo dalle storie delle persone. Un estratto di queste testimonianze - tutte di ragazze e ragazzi giovani, sotto i trent’anni - si possono ascoltare anche in questo podcast dal quale emerge come ci siano pezzi del racconto sulle scelte relative al diventare o meno genitori ancora in ombra nella narrazione pubblica. Hanno a che fare moltissimo con le preoccupazioni per la crisi climatica e geopolitica, con la stabilità psicologica, con nuove forme di consapevolezza personale e di coppia: questioni che, forse, noi intorno agli -anta sentiamo meno pressanti, ma che sono rilevantissime per i più giovani. E poi, c’è lo “storytelling”: lo spiega benissimo una delle ragazze intervistate: se cresci vedendo l’enorme fatica che fanno i tuoi genitori e intorno a te senti parlare di genitorialità prevalentemente in termini di stanchezza e rinunce, forse tanta voglia di fare un figlio poi è normale che non ti venga. Su questo punto, la redazione di “Vita” ha chiesto anche a 25 tra esperti di educazione, psicologia e comunicazione di indicare quali siano, secondo loro, le parole dello storytelling di oggi sulla genitorialità e quali, invece, quelle che mancano. Ne è uscito un vocabolario molto interessante, sul quale riflettere per provare a immaginare modi di essere genitori diversi a partire proprio dalle parole (un estratto si trova qui).
Una newsletter
Mentre scrivo, mi accorgo che, come spesso accade, anche in questo caso i libri sono il filo rosso della mia esplorazione. Forse è per questo che mi è piaciuto da subito il progetto “Scuola” di Terre di Mezzo, che ho scoperto poche settimane fa: una newsletter e una pagina dedicata sul sito della casa editrice che parlano di scuola e alla scuola partendo dai libri. È uno spazio pensato in modo particolare per gli insegnanti, ma non solo: ci sono proposte di lettura, idee per laboratori, approfondimenti su temi specifici, appuntamenti di formazione, interviste ad autori, materiali da scaricare. Che bello!
Una bella storia
Ancora libri, lo so, ma a questo punto seguiamo l’onda. La genitorialità c’entra poco, ma c’è molto villaggio - quello delle comunità delle terre alte che talvolta, noi di città, aneliamo inseguendo una visione idilliaca e un po’ stereotipata (ancora a proposito di narrazioni da decostruire), ma che in realtà conosciamo molto poco - in “La strangera”, di Marta Aidala. Racconta la storia di Bea, una ragazza che lascia la città per andare a lavorare in un rifugio, in cerca di una montagna nella quale rimanere e di sé stessa. Poco meno di un anno nel quale la vetta che tanto ama le mostrerà ogni suo volto, non sempre benigno. È il romanzo più bello che ho letto in questo scorcio di fine anno: se cerchi una storia che ti faccia compagnia nei giorni di festa, te lo consiglio: leggilo e poi mi dici.
Un parola
Infine, una parola. Nelle ultime settimane mi è capitato di partecipare a due funerali. Non mi succedeva da tempo. Sono mancati i genitori di cari amici e colleghi, persone provate da lunghe e terribili malattie, delle quali le loro famiglie si sono prese cura con dedizione e affetto, spesso tra molte difficoltà. Secondo la Treccani la parola del 2024 è stata “rispetto”. Ecco, io spero che quella del 2025 sarà “cura”. A pensarci bene, la cura è ovunque e ha mille sfaccettature: è quella che riserviamo alle persone e alle cose che amiamo, quella che può rendere più belli gli spazi fisici e sociali che abitiamo, quella che spesso manca e che andrebbe distribuita e condivisa meglio, quella di cui dovrebbero farsi carico di più le istituzioni. La cura è ciò che sorregge (o meno, se manca) le relazioni che danno forma al nostro essere comunità e, in fondo, caratterizza il nostro essere umani. Che sia, allora, quello che verrà, un anno nuovo fatto di cura reciproca.
Come promesso, è stata un newsletter un po’ più corta del solito (forse). Queste ultime righe le tengo per augurarti buone feste: siamo tutte e tutti un po’ stanchi, un po’ preoccupati, un po’ demotivati. Io provo a guardare al 2025 con lo sguardo pieno di meraviglia di mia nipote, che ha appena compiuto due anni e ultimamente, davanti alle cose nuove, ha imparato a dire: wow! Cose nuove e belle, continuo a credere fermamente, aspettano anche noi, che di anni ne abbiamo qualcuno in più. Alcune continuerò a raccontarle in questo spazio, nel nostro villaggio, del quale spero che tu continuerai a far parte e che io proverò a rendere il prossimo anno più bello, più utile, più villaggio.
Passa dei buoni giorni, noi ci leggiamo a inizio 2025 🧡
“Ci vuole un villaggio” è la newsletter che prende spunto da ciò di cui parlano i genitori la mattina fuori da scuola per provare ad allargare lo sguardo. Perché ho scelto questo titolo e il senso di questa newsletter, lo trovi spiegato meglio qui, nel primo numero.
Io sono Silvia De Bernardin, giornalista freelance e mamma. Da anni scrivo di genitorialità, ma anche di lavoro, salute, alimentazione, sostenibilità e turismo, tutte cose che hanno a che fare l’una con l’altra molto più di quanto sembri. Qui ci troverai anche un po’ di questi temi. Mi trovi anche su Instagram e Linkedin e sulle pagine digitali, cartacee e social di Giovani Genitori, Vegolosi MAG e Job in Tourism.





Ciao Silvia, buon Natale e buone feste, ci leggiamo l’anno prossimo!
Grazie Silvia è un regalo molto prezioso questa newsletter di Natale: tantissimi auguri e a presto